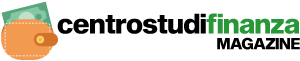Cosa può nascondere la stanchezza cronica - centrostudifinanza.it
Le informazioni mediche fornite devono sempre essere integrate dal parere specialistico, considerando la complessità e la variabilità individuale.
La leucemia linfatica cronica (LLC) rappresenta la forma più diffusa di leucemia nell’adulto nei Paesi occidentali, caratterizzata da una crescita anomala e incontrollata di un sottogruppo di linfociti B.
Questo tumore ematologico coinvolge un progressivo accumulo di queste cellule nel sangue, nel midollo osseo e negli organi linfatici, come linfonodi e milza.
La leucemia linfatica cronica: caratteristiche e diffusione
La LLC si manifesta prevalentemente in età avanzata, con un’età media alla diagnosi di circa 72 anni, e colpisce maggiormente gli uomini. Ogni anno, nel mondo occidentale, si registrano circa 5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, coprendo circa il 30% di tutte le leucemie diagnosticate. La malattia si sviluppa quando un linfocita B subisce alterazioni genetiche e riceve stimoli dall’ambiente circostante che ne favoriscono la moltiplicazione, dando origine a un clone cellulare che si accumula lentamente nel tempo.
I fattori di rischio includono componenti genetiche e familiari, con un’incidenza più elevata tra i parenti di primo grado di pazienti affetti. Riguardo ai fattori ambientali, si ipotizza un legame con l’esposizione prolungata a determinati pesticidi, anche se le evidenze sono limitate.
Sintomi e diagnosi della leucemia linfatica cronica
Spesso la LLC viene scoperta casualmente attraverso esami del sangue eseguiti per altre motivazioni o dall’ingrossamento indolore di linfonodi nel collo, ascelle o inguine. Nei casi più avanzati, la malattia può manifestarsi con anemia, causata dalla diminuzione dei globuli rossi, che si traduce in stanchezza, pallore e respiro affannoso, nonché con piastrinopenia, che raramente provoca sanguinamenti.
L’aumento dei linfociti tumorali compromette la produzione delle altre cellule immunitarie, rendendo i pazienti più vulnerabili a infezioni di varia gravità.
L’esame diagnostico di base è un prelievo ematico che evidenzia una linfocitosi persistente, ovvero un numero di linfociti superiore a 5.000/mm³. L’iter diagnostico si completa con esami specialistici come l’immunofenotipo, che distingue le cellule leucemiche da quelle normali, e in alcuni casi con biopsie linfonodali, soprattutto se non si riscontra linfocitosi nel sangue periferico.
La stadiazione della malattia, fondamentale per pianificare il trattamento, si basa su sistemi come quello di Rai o di Binet, che valutano parametri clinici e laboratoristici per classificare la gravità.
Trattamenti e gestione della malattia
La leucemia linfatica cronica ha un decorso variabile: molti pazienti possono vivere per anni senza necessità di terapie, adottando un approccio di “vigile attesa” con monitoraggi regolari. Il trattamento inizia solo con l’insorgenza di sintomi significativi o complicazioni, come anemia grave, ingrossamento importante dei linfonodi o della milza, o manifestazioni autoimmuni che non rispondono ai corticosteroidi.

Negli ultimi anni, la gestione terapeutica ha subito una rivoluzione grazie all’introduzione di farmaci biologici mirati, come gli inibitori di BTK e di BCL2, abbinati ad anticorpi monoclonali anti-CD20 come obinutuzumab.
Questi trattamenti a bersaglio molecolare sono più efficaci e tollerati rispetto alla tradizionale chemioterapia, migliorando sensibilmente la prognosi e la qualità di vita dei pazienti. L’immunochemioterapia rimane indicata solo per una selezione ristretta di pazienti con mutazioni genetiche favorevoli.
Nonostante i progressi, le terapie attuali non garantiscono la guarigione definitiva; tuttavia, in caso di recidiva, è possibile ricorrere a successivi trattamenti che prolungano il controllo della malattia. Per i pazienti giovani con malattia resistente a più linee di terapia o con evoluzione in linfoma aggressivo (sindrome di Richter), il trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche può rappresentare una valida opzione.
Le indagini genetiche, in particolare lo studio delle mutazioni del gene TP53 e dello stato di mutazione dei geni IGHV, sono fondamentali per personalizzare il percorso terapeutico e prevedere la risposta ai farmaci.