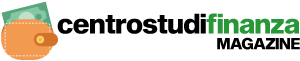L’azienda e il suo valore di capitale economico
Valutare un’azienda significa attribuire un valore al suo capitale, e quindi valorizzare parimenti i diritti di pertinenza dei proprietari di tale capitale.Dal punto di vista economico-aziendale l’azienda (definita dall’art. 2555 del Codice Civile come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”) è qualificata come un sistema organico e coordinato di risorse materiali ed immateriali, le quali costituiscono il mezzo attraverso il quale l’imprenditore esercita un’attività.
L’organizzazione e la coordinazione dei fattori produttivi aziendali si manifestano quindi nella grandezza dell’avviamento, inteso come questo “l’attitudine dell’impresa a produrre utili in maniera superiore a quella ordinaria”, attitudine che trova espressione quantitativa nella differenza tra il valore globale dell’azienda e la somma algebrica del valore corrente dei beni che fattori che, inerenti al complesso aziendale, ne formano il “capitale investito”. L’avviamento (che può essere positivo o negativo) è un concetto intrinsecamente compreso in quello di azienda, nel senso che concorre in modo imprescindibile alla sua qualificazione; da questo ne discende in via immediata che una valutazione d’azienda “razionale” difficilmente può prescindere dalla sua considerazione.
Il concetto di “valore”
Una classica definizione di azienda, ampiamente diffusa, è quella di “investimento unitario atto a produrre reddito”.Questo approccio, benché riduttivo nel considerare un’entità complessa come quella aziendale come un puro investimento economico (l’azienda può essere considerata altresì un mezzo attraverso il quale raggiungere molteplici obiettivi, anche non strettamente economici) ha il significativo pregio di dare importanza, in maniera complementare, a “valori di stock” (l’investimento unitario, o capitale investito) ma anche, e soprattutto, a “valori di flusso” (il reddito, o risultato d’esercizio). In tal modo il concetto stesso di azienda perde ogni connotazione di staticità in quanto va necessariamente a comprendere al suo interno anche aspetti della gestione “futura”, momento nel quale il coordinamento e l’organizzazione dei fattori produttivi, elementi come detto sopra qualificanti l’idea stessa di azienda, troveranno la loro completa e integrale manifestazione nella grandezza del reddito. L’impostazione sopra descritta è stata nel tempo sostituita da un’altra, che della prima costituisce un‘evoluzione, la quale considera come obiettivo economico primario dell’azienda non tanto la produzione di reddito quanto la “creazione di valore”; parallelamente (e di conseguenza) si sono diffusi metodi di valutazione il cui intento è quello di andare a cogliere e quantificare questa nuova dimensione. Secondo questo approccio, il “vero” risultato di esercizio non è il reddito, o almeno non il reddito determinato contabilmente in ottemperanza delle comuni disposizioni civilistiche; viene osservato infatti (ad esempio nei mercati di Borsa) che a risultati di bilancio positivi si possono accompagnare decrementi nel valore dell’azienda (che nell’esempio in questione si riflettono sulla flessione dei corsi azionari).Si sta facendo riferimento alla c.d. “Teoria del valore”. Data l’importanza che essa riveste, si ritiene opportuno ripercorrere brevemente il percorso logico che ne sta alla base. Un complesso aziendale per “funzionare “ ha di fatto continuamente bisogno che in esso siano investite delle risorse (che possono essere apportate a vario titolo), le quali vanno in primo luogo reperite, e quindi (in un mondo in cui esse sono “scarse” o comunque limitate) remunerate. Il costo di queste risorse è un fattore che l’azienda non può in genere controllare: l’esistenza del “mercato” (e quindi di investimenti alternativi) fa sì che il prezzo (e dunque, in maniera speculare, il costo) di queste sia determinato dal confronto tra domanda e offerta, e quindi solo in minima parte influenzabile (in misura nulla in un mercato “perfetto”) dalla singola impresa. Gli investimenti alternativi si caratterizzano poi per diversi livelli di rischio; colui che apporta risorse e si carica di parte o di tutto il rischio dell’investimento chiederà di essere remunerato in maniera congrua al rischio sopportato, in quanto l’esistenza del “mercato” gli permette altrimenti di dirigersi verso altri investimenti che presentano livelli di rendimento adeguati in relazione alla quantità di rischio che essi incorporano.L’azienda deve di conseguenza remunerare in maniera adeguata tutte le risorse che vengono in essa a vario titolo investite; questo vale sia per quelle che presentano un costo esplicito, che per quelle che hanno un costo implicito (costo o onere “figurativo”).La Teoria del valore afferma a questo appunto che l’impresa aumenta il proprio valore solo nel momento in cui il risultato di esercizio, al netto della remunerazione (esplicita ed implicita) di tutte le fonti di finanziamento (in maniera congrua al livello di rischio che esse sopportano) è positivo. Di conseguenza, un’impresa i cui risultati nel tempo sono appena in grado di remunerare le risorse a vario genere in essa investite (tenuto conto dei diversi livelli di rischio che esse “sopportano”) senza essere in grado di generare una “redditività soddisfacente” o meglio degli “extra-risultati”, idea alla quale si rifanno in vario modo i concetti di “extra-profitto”, di “reddito residuale” e di “valore economico aggiunto” non crea di per sé valore: le stesse risorse avrebbero infatti potuto trovare analoga remunerazione se impegnate in investimenti alternativi, o, in altri termini, nel “mercato”. Ne deriva di conseguenza che un’impresa in grado di generare risultati di bilancio positivi, ma non tali da remunerare in maniera adeguata le risorse che hanno permesso a quegli stessi risultati di essere conseguiti, “distrugge valore”. Queste considerazioni, traslate nell’ambito del settore della Valutazione d’Azienda, portano a concludere che il valore attribuibile ad un complesso aziendale è funzione diretta della sua capacità di “creare valore”. La Teoria del valore mette inoltre in evidenza che la “creazione di valore” deve essere considerata come un obbiettivo aziendale imprescindibile, in condizioni di libera economia, in quanto strettamente connessa con la sopravvivenza dell’azienda stessa.Un complesso aziendale che “distrugge valore” non è infatti in grado di remunerare in modo adeguato le risorse in esso investite, motivo per il quale difficilmente individui razionali impiegheranno in esso altre risorse nel momento in cui ciò si rendesse necessario (risorse che potrebbero infatti trovare una remunerazione adeguata nel “mercato”). In tal modo (vale a dire in assenza di risorse finanziarie) la possibilità dell’azienda di perdurare nel tempo in condizioni di equilibrio viene generalmente ad essere compromessa.
Il concetto di capitale economico
Per comprendere a cosa ci si riferisca con l’espressione “capitale economico” può essere utile in primis andare brevemente a descrivere in quali modi la nozione di capitale d’impresa si presta a essere declinata, a seconda delle ipotesi formulate circa gli svolgimenti della gestione futura (Pellati e Rinaldi, 2005).La dottrina distingue tre accezioni principali:
- assumendo l’ipotesi di continuità della gestione aziendale con il medesimo assetto proprietario, si definisce “capitale di funzionamento” (o “di bilancio”) la ricchezza a disposizione dell’impresa per lo svolgimento della gestione futura; tale grandezza trova rappresentazione nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio, come differenza tra poste attive e passive, e costituisce un valore di natura astratta, unico e inscindibile la cui determinazione è fondamentalmente condizionata dalle finalità, dai vincoli e dai principi che disciplinano la redazione del documento di bilancio;
- se si ipotizza la cessazione dell’attività aziendale e la liquidazione del patrimonio, si perviene alla nozione di “capitale di liquidazione”, inteso come entità data della mera somma dei valori assegnabili ai singoli beni che sono inclusi nel complesso aziendale, al netto delle obbligazioni ancora da assolvere. In fase di liquidazione vengono meno le relazioni di complementarietà ed interdipendenza tra i beni; non ha allora più senso allora considerare l’azienda come “investimento”, per cui la destinazione economica dei beni viene ad essere modificata a oggetti di scambio. Essi vengono stralciati dalla combinazione produttiva e, poiché non più suscettibili di utilità futura, valutati in base al presunto valore di realizzo sul mercato.
- se si intende assegnare un valore all’azienda, ad esempio nei casi di cessione delle quote sociali, conferimento d’azienda ed in generale in tutte le transazioni che comportano il “trasferimento dell’azienda” non lo si fa (eccetto che in casi eccezionali) avendo a riferimento le due nozioni di capitale in precedenza descritte: anche l’adoperare la nozione di “capitale di funzionamento” comporterebbe infatti (di norma) una notevole sottostima del valore correttamente attribuibile al complesso aziendale. Il valore dell’azienda è invece rappresentato dal suo valore di capitale economico, inteso come grandezza comprensiva di ogni elemento in grado di contribuire alla futura produzione di ricchezza. In altri termini, il “capitale economico” è l’entità che rappresenta il valore dell’azienda, e che, in quanto tale, è in grado di meglio approssimare il valore di scambio della stessa; questo è il motivo per cui ad esso si fa riferimento nell’ambito delle negoziazioni di aziende. L’inadeguatezza del capitale di funzionamento ad esprimere correttamente il valore attribuibile ad un complesso aziendale è dettata dal fatto che la sua determinazione è condizionata dalle finalità del bilancio di rilevare il reddito di esercizio nel rispetto dei principi di competenza e di prudenza, non riuscendo quindi normalmente ad esprimere quanto possa valere l’impresa tout court , vale a dire alla luce delle sue prospettive future.
Questo deriva, a titolo esemplificativo, da:
- il valutare le attività al costo storico, al netto dei fondi ammortamento, senza considerare (se non in casi eccezionali) gli eventuali incrementi di valore;
- dalla difficoltà nell’iscrivere beni che sono pur generatori di utilità futura, quali i beni intangibili, il cui valore, se non fosse spesato integralmente nell’esercizio, andrebbe ad aumentare la dotazione patrimoniale dell’impresa.Attraverso l’eventuale effettuazione delle suesposte rettifiche non si perverrebbe comunque alla determinazione di un’entità che può essere razionalmente definita di “capitale economico”, in quanto si giungerebbe comunque ad un valore dato dalla somma algebrica dei valori attribuiti a singole componenti patrimoniali.Il capitale economico è, al contrario, “un valore unico, risultante dalla capitalizzazione dei redditi futuri”.
Quest’affermazione, che può essere senz’altro considerata una delle “pietre miliari” della Scuola italiana di Economia Aziendale, viene al giorno d’oggi universalmente accettata nella sua impostazione di fondo, vale a dire nel considerare il valore del capitale delle aziende come il risultato dell’attualizzazione di grandezze di flusso che un’azienda “genera” nel tempo (dividendi, redditi, flussi di cassa o “valore economico aggiunto”, a seconda del metodo utilizzato) e non come la semplice considerazione del valore di stock che può essere attribuito, in un dato momento, ad un complesso aziendale (dato dalla somma algebrica dei valori attribuibili alle singole componenti patrimoniali).Questo in quanto, citando ancora una volta Zappa, “gli investimenti d’impresa non hanno economicamente valore capitale che in quanto fruttano redditi” o altresì, facendo riferimento alle parole del fondatore della scuola tedesca di Economia Aziendale, “chi vuole acquistare un’impresa, ha un interesse economico rivolto solo ed esclusivamente ai proventi che dall’impresa nel futuro sappia ricavare”.In sostanza, secondo quest’impostazione, l’unitarietà degli elementi aziendali (che è per l’appunto un punto cardine della dottrina aziendalistica italiana) viene ad essere assunta quale determinante stessa del valore attribuibile a un complesso aziendale, in quanto le determinanti una certa entità di capitale economico non sono i valori attribuibili ai singoli elementi patrimoniali, presi distintamente e sommati, ma sono al contrario quei redditi futuri che costituiscono il risultato inscindibile della coordinazione unitaria impressa dall’imprenditore al complesso aziendale.Parimenti, ancora il Zappa ribadisce come per capitale economico si debba intendere il “valore di un unico complesso economico, costituito da fattori complementari tali da non consentire una loro distinta valutazione per pervenire alla conoscenza del complesso valore che si vuole determinare”.Si deve rilevare che i concetti appena richiamati, risalenti agli anni venti del secolo scorso, non hanno tuttavia per molti decenni trovato generale riscontro nel settore della Valutazione d’Azienda (in special modo nelle valutazioni eseguite nell’Europa Continentale): i metodi di valutazione più utilizzati sono stati infatti i c.d. “metodi patrimoniali” o “ispirati al patrimonio”, i quali nella loro impostazione più pura prescindono totalmente dalla considerazione dei risultati futuri (stimati) generati dal complesso aziendale del quale dovrebbero esprimere il valore.La consapevolezza, nell’ambito della Valutazione d’Azienda, che i metodi di valutazione del capitale economico fondati sui flussi (reddituali o finanziari) sono “i soli ad essere sicuramente razionali ed universali” è recente, e alla sua affermazione ha contribuito in maniera non trascurabile l’influenza della Scuola Anglosassone, in particolare con le valutazioni prodotte e diffuse dagli analisti finanziari e dalle banche d’affari.
Il capitale economico e le altre nozioni di capitale
Definito cosa si intende per capitale economico (concetto che sottintende l’idea di impresa considerata come un’entità unitaria finalizzata alla produzione di ricchezza) si rivela spesso utile il confronto con le altre nozioni di capitale in precedenza individuate, dal quale emergono le seguenti considerazioni:
- un’impresa in cui il cui capitale di funzionamento, o “di bilancio”, risulta superiore al valore di capitale economico è un’impresa in cui l’organizzazione dei beni e la destinazione unitaria degli stessi col fine di produrre ricchezza non possono dirsi conseguite “con successo”, in quanto nel complesso l’impresa, tramite i suoi risultati futuri, non genera un valore superiore a quello delle singole poste patrimoniali che partecipano allo svolgimento delle operazioni aziendali, valutate con criteri di “funzionamento”. Questa situazione implica peraltro che il valore globalmente attribuito alle singole componenti patrimoniali non è “economicamente sostenibile”; in altri termini, l’assegnare un valore alle poste patrimoniali che non è poi “recuperabile tramite l’uso” (il che si verifica, ad esempio, nel momento in cui l’ammortamento delle immobilizzazioni non trova capienza nei redditi futuri) non è razionalmente compatibile con il considerare l’azienda come un istituto finalizzato alla futura produzione di ricchezza (nel caso specifico, il valore delle poste patrimoniali dovrebbe essere “svalutato” per la parte non più recuperabile tramite l’uso negli esercizi successivi). In conclusione, per quanto detto, il valore del capitale economico d’azienda dovrebbe essere considerato il limite massimo a cui il capitale di funzionamento della stessa può essere valutato.
- quando il valore di capitale economico aziendale risulta essere addirittura inferiore al “capitale di liquidazione”, si ha che il valore attribuibile ai “risultati futuri” è minore del valore assegnabile all’immediata cessione dei singoli beni aziendali (stralciati dalla combinazione produttiva); in questo caso l’azienda stessa non avrebbe ragione economica di esistere, e l’alternativa più conveniente e più razionale sarebbe per l’appunto la liquidazione. Da ciò discende che il valore del “capitale di liquidazione” è la grandezza-limite al di sotto della quale una stima di capitale economico non può razionalmente spingersi.
I criteri della Valutazione d’Azienda
Nel paragrafo precedente si è visto come il capitale economico costituisca il limite superiore a cui il capitale di funzionamento dovrebbe essere valutato e con gli stessi argomenti si è dimostrato che una valutazione razionale del capitale economico di un’azienda non può scendere al di sotto del valore di liquidazione della stessa. Non gli si è in tal modo posto un limite massimo, che in effetti non è aprioristicamente individuabile (e né avrebbe senso individuarlo); una valutazione di capitale economico potrebbe, per quanto rilevato, condurre a qualunque valore superiore al valore di liquidazione dello stesso complesso aziendale.Ponendosi l’obiettivo di delimitare in qualche modo il campo dei possibili valori determinabili, si conclude che questo è possibile solo nel momento in cui si impone alla valutazione d’azienda (e più correttamente a tutto il processo valutativo) di rispettare alcuni principi e criteri.A questo riguardo Luigi Guatri, (che è generalmente considerato l’esponente più autorevole della Scuola Italiana di Valutazione D’Azienda) afferma che “la valutazione di un azienda si ispira a concetti, criteri e metodi ai quali si chiede di esprimere una misura dotata del più alto grado possibile delle seguenti caratteristiche: razionalità, dimostrabilità, neutralità e in qualche caso stabilità”.Affinché una valutazione d’azienda rispetti il basilare criterio della razionalità, essa deve derivare da un processo logico chiaro e convincente, e come tale largamente condivisibile. Il processo logico chiaro e convincente che sta alla base del processo valutativo deve quindi necessariamente tradursi in una formula valutativa, la quale deve possedere le caratteristiche della dimostrabilità e neutralità; in particolare: · la dimostrabilità comporta la “possibilità di attribuire ai fattori che entrano nella predetta formula valutativa grandezze supportate da dati controllabili”;
- neutralità significa escludere dal processo valutativo scelte arbitrarie e immotivate, decisioni non disinteressate e perciò influenzanti senza ragione i risultati delle stime.In effetti è immediato riscontrare che per valutare un’azienda possono essere proposte una molteplicità di metodologie e formule; non tutte derivano però da un processo logico chiaro e convincente: non tutte sono cioè razionali. In particolare, in quest’ambito, la ragionevolezza di una formula si basa sulla sua attitudine a catturare le leve del valore e ad esprimere, attraverso una relazione di tipo matematico, il legame tra le leve (o “determinanti”) del valore e il valore stesso.Autorevole dottrina ha a questo riguardo individuato il Dividend Discount Model (DDM) come “l’unico modello teorico per la stima del valore aziendale, se fossimo in grado di prevedere analiticamente i flussi di risultato di un’azienda in una prospettiva infinita”. Tale modello infatti cattura le determinanti del valore (vale a dire “i flussi” e “i tassi”) e nello specifico va a considerare proprio quei flussi di risultato che essendo percepiti dagli investitori-azionisti determinano sia il valore che il rendimento dell’investimento da essi effettuato.La formula è la seguente:
∞
W = ∑ DIV/(1+i)t
t=1
con:
W = valore di capitale economico;DIV = flusso di dividendo;i = tasso di attualizzazione.
La predetta formula risulta essere coerente con quanto afferma la Teoria finanziaria, ovvero che il valore di qualsiasi investimento è funzione dei proventi attualizzati che un investitore percepisce dall’investimento stesso.Considerando dunque l’azienda alla stregua di un qualsiasi investimento economico, la formula del DDM ne definisce il valore come somma di tutti i dividendi percepiti dall’azionista, senza limiti di tempo. D’altra parte, poiché la percezione dei dividendi non è immediata ma si distribuisce nel tempo parallelamente allo scorrere della vita aziendale, e dal momento che gli stessi flussi di dividendi non possono essere mai determinati con assoluta certezza (sono cioè “flussi rischiosi”, in cui la rischiosità è data dai possibili scostamenti dei dividendi futuri dalla media dei valori previsti) è necessario determinare un tasso (“i”, nella formula di cui sopra) attraverso il quale scontare i dividendi percepiti nel futuro, che tenga conto sinteticamente sia dello scorrere del tempo che del grado di rischio associato agli stessi dividendi.
Il “terminal value”
Nessuno è in grado di prevedere con precisione e ragionevolezza i flussi di dividendo futuro su un periodo di tempo molto esteso. L’arco temporale di previsione esplicita infatti può di norma coprire i primi tre o cinque esercizi (questo in funzione sia di fattori esogeni, quali la turbolenza che caratterizza lo specifico settore in cui l’azienda opera, sia endogeni, quali ed esempio la stabilità del management), assai raramente si spinge fino ai dieci; previsioni analitiche di dividendi (e di altri risultati aziendali, quali redditi e flussi di cassa) che si spingono oltre non vengono infatti considerate significative, in quanto assimilabili più a “scommesse” che a previsioni dotate di significato.
D’altra parte nel valutare un’azienda difficilmente si può prescindere dalla considerazione dei risultati futuri che essa sarà in grado di generare; infatti, dal momento che il valore attribuibile ad un complesso aziendale è funzione tendenzialmente di tutti i risultati da questo prodotti nel tempo, e stante d’altra parte la natura dell’azienda quale istituto a vita generalmente indefinita, ne discende la necessità (o quantomeno l’opportunità) di considerare in qualche modo anche i risultati da essa scaturenti oltre l’orizzonte di previsione analitica.Si pone pertanto il problema di come conciliare due “situazioni” contrapposte:
– da un lato la natura dell’azienda quale “istituto atto a perdurare”, la cui “vita” è tendenzialmente infinita, o comunque la cui durata è, più generalmente, indefinita;
– dall’altro l’impossibilità di spingere le previsioni analitiche di risultato, dotate di un minimo grado di significato, oltre un certo orizzonte temporale.La soluzione adottata nel campo della valutazione d’azienda consiste nell’adottare modelli di valutazione che facciano ricorso a previsioni di risultato analitiche ed esplicite per un numero limitato di anni, e che siano in grado di catturare in forma sintetica la capacità medio-normale d’impresa di produrre risultati oltre il periodo di previsione analitica.Si tratta in altri termini di riassumere in un unico fattore (detto “valore terminale” o terminal value) il valore di tutti quei risultati futuri la cui previsione analitica, vale a dire effettuata anno per anno, sarebbe dotata di scarso significato. Il terminal value assume di norma un peso notevole sul risultato totale della valutazione (peso che non di rado arriva anche all’80%); a questo si accompagna l’elevata difficoltà nella stima dei termini da considerare nel calcolo dello stesso, in quanto si tratta, in sostanza, di calcolare il valore attribuibile all’azienda al termine dell’orizzonte di previsione analitica (quindi generalmente il suo valore tra tre o cinque anni), valore (futuro) che sarà poi attualizzato ad un tasso opportuno per esprimerlo in termini di valore attuale.Pertanto, assumendo una prospettiva temporale finita, il Dividend Discount Model viene ad essere così modificato:
TW = ∑ DIV/(1+i)t + TV/(1+i)T
t = 1
in cui TV = terminal value.
Si apre però in questo modo un altro problema nell’ambito della determinazione del capitale economico, vale a dire la definizione dei termini che entreranno nel calcolo del terminal value.In particolare, il valore-flusso che sta al numeratore nella formula del terminal value è nella prassi frequentemente ottenuto attraverso la proiezione dei risultati stimati nell’orizzonte di previsione analitica, nella convinzione che i risultati puntualmente previsti nei primi n anni siano i migliori stimatori dei risultati da lì in seguito. Questo procedimento, dotato comunque di un certo grado di razionalità, non è sempre corretto; molto spesso è necessario apportare delle correzioni, più o meno consistenti, in funzione della configurazione dei risultati-flussi che vengono proiettati nel terminal value. Risultati per loro natura erratici e discontinui difficilmente sono idonei ad esprimere in forma sintetica (ad esempio attraverso il calcolo di un loro “valore medio”) la capacità medio-normale dell’impresa di produrre risultati oltre l’orizzonte temporale di previsione analitica, per cui una loro proiezione nel futuro attraverso il calcolo del valore terminale potrebbe portare a valori scorretti, in assenza di interventi di correzione e “normalizzazione”. Questa “normalizzazione” si rende per l’appunto necessario ogni qualvolta in cui i flussi oggetto di previsione esplicita (quindi i flussi determinati nei primi n anni) sono degli stimatori distorti dei flussi che si avranno in futuro, ed in quanto tali non sono in grado di stimare correttamente un flusso medio-normale da proiettare e quindi non adatti ad apprezzare la capacità prospettica dell’impresa di generare risultati. Nella prassi non è per niente raro che questo flusso medio-normale sia determinato sic et simpliciter considerandolo uguale al flusso dell’ultimo anno del periodo di previsione esplicita, prescindendo pertanto anche da quella (minima) operazione di normalizzazione che si ottiene calcolando la media aritmetica dei flussi previsti analiticamente. Si tratta di un procedimento che non è di per sé sempre scorretto, ma del quale dovrebbero esser pur sempre chiari i presupposti e le conseguenze.
Una prima analisi di alcuni modelli di determinazione del capitale economico
Alla luce di quanto esposto al paragrafo precedente, si possono fare delle prime considerazioni su alcuni modelli di valutazione del capitale “basati sui flussi”, la bontà dei quali, per quanto detto, deve essere valutata anche in relazione alla loro attitudine e capacità di catturare i flussi di risultato rilevanti da proiettare nel terminal value.Con queste premesse non stupisce il fatto che il DDM (che come si è visto rappresenta in linea teorica la “formula generale” e più razionale di valutazione del capitale economico) non sia alla prova dei fatti un criterio valutativo molto utilizzato; questo in quanto non si ritiene generalmente che i dividendi stimabili nel periodo di previsione esplicita possano essere dei validi stimatori dei dividendi elargiti dall’impresa in perpetuum.
In effetti, essendo l’ammontare dei dividendi distribuiti frutto in genere di scelte in buona dose discrezionali (nel senso che non è generalmente ravvisabile un legame funzionale diretto e stabile nel tempo tra dividendo distribuito anno per anno e le altre configurazioni di risultato aziendale, quali il reddito e il flusso di cassa, il che semplificherebbe ovviamente la questione), risulta assai arduo stimare un dividendo medio-normale che l’impresa distribuirà in futuro. Un semplice esempio può essere rappresentato dall’impresa che, pur conseguendo redditi positivi, attua una politica di ritenzione dei dividendi per i primi n anni, la quale non pregiudica ma anzi a certe condizioni aumenta la potenzialità di distribuzione di dividendi nei successivi esercizi; è chiaro che in questo caso la determinazione di un dividendo “medio-normale” stimato utilizzando i dati dei primi n anni non avrebbe molto significato. Una certa stabilità riguardo i flussi di dividendo distribuiti è ravvisabile per quanto riguarda le società quotate in borsa; in questo caso essa si lega peraltro ad altre variabili, tra le quali le aspettative degli investitori azionisti che interpretano la predetta stabilità (o gli eventuali cambiamenti della ”politica dei dividendi”) come una sorta di “segnale”.Comunque, fatta eccezione per alcuni casi, la teoria e la prassi ricorrono pertanto ad altri modelli di valutazione del capitale che prendono in considerazione risultati più stabili nel tempo (redditi, e in misura minore i flussi di cassa), la determinazione dei quali è soggetta a minori “gradi di libertà” rispetto alla scelta, di norma notevolmente discrezionale, del dividendo da distribuire.I modelli proposti dalla dottrina e dalla prassi vanno comunque vagliati per mettere in luce la loro consistenza teorica con il modello DDM, che, seppur in genere difficilmente applicabile, rimane il modello teorico generale di valutazione.
Le scuole di valutazione aziendale dell’Europa Continentale (quella Italiana e Tedesca su tutte) si sono nel tempo rese sostenitrici del metodo reddituale quale metodo di determinazione del capitale economico dotato del maggior grado di razionalità. Questa convinzione discende dalla considerazione che una valutazione d’azienda è tanto più ragionevole quanto più ad essa si perviene considerando i “veri risultati” prodotti nel tempo dal complesso aziendale, e dalla convinzione per l’appunto che il “vero risultato” prodotto nel tempo sia il reddito e non, ad esempio, il flusso di cassa. Questo perché, come afferma M. Bini: “Il flusso di risultato da scontare non può essere costituito da un flusso che – come il flusso di cassa – non garantisce la conservazione del capitale”.In sostanza, in questa fattispecie si sostituiscono nella formula del DDM (in precedenza riportata) i redditi stimati ai dividendi stimati.
A questa impostazione si contrappone quella della scuola Anglosassone, la quale individua nella massimizzazione del flusso di cassa positivo il vero obiettivo cui tendono le imprese, e coerentemente con ciò propone un metodo di valutazione (conosciuto con il nome di Discounted Cash Flow, più brevemente DCF) basato sull’attualizzazione dei flussi monetari che si stima l’impresa sia in grado di generare in futuro, sostituendoli pertanto ai dividendi nella formula generale del DDM.Come autorevole dottrina ha rilevato, l’idea che sta alla base del DCF è tanto semplice quanto robusta: nel lungo termine nessun impresa può distribuire dividendi in misura superiore alla sua capacità di generare cassa; il modello in questione soffre tuttavia di un limite similare a quello del DDM, vale a dire la non sempre adeguata attitudine dei flussi di cassa previsti nel breve periodo (quale per forza di cose è il periodo di previsione esplicita) ad essere degli stimatori corretti di un flusso medio-normale proiettabile in perpetuum.Nel corso del tempo la disputa tra le diverse scuole e in generale tra i sostenitori del metodo reddituale e di quello finanziario si è giocata sul confronto tra due tesi contrapposte:
- da un lato, l’innegabile capacità della grandezza-reddito di esprimere (specie nel breve periodo) in modo più pertinente il “risultato d’esercizio”, rispetto al puro flusso di cassa; in effetti “nessuno si sognerebbe di affermare che la differenza tra il saldo finanziario all’inizio dell’anno e quello esistente alla fine sia il risultato conseguito nell’anno: senza tenere conto degli ammortamenti, della variazione del magazzino, della dinamica dei fondi spese future e dei fondi rischi, e così via”;
- dall’altro, l’essere il flusso monetario una configurazione di risultato oggettiva (o se non altro “meno discrezionale” rispetto al reddito), in quanto la sua determinazione non è in larga misura influenzata dalle politiche di bilancio (ad esempio, dalla sopravvalutazione delle rimanenze) e da tutte quelle rettifiche ed assestamenti (che richiedono in effetti un certo grado di discrezionalità) che si apportano per determinare il reddito “di competenza” dell’esercizio; a questo si aggiunge la caratteristica del flusso di cassa di essere un risultato immediatamente consumabile (in quanto trattasi a tutti gli effetti di liquidità “liberata”).A ben vedere, questa contrapposizione ruota in gran parte attorno all’opinione sul ruolo e sull’utilità delle rettifiche da apportare per giungere alla determinazione del reddito dell’esercizio “per competenza”; infatti, considerato che:
R = CF ± RC
dove:
R = risultato dell’esercizio;CF = flusso finanziario;RC = scritture di rettifica ed assestamento (accruals e defferals, in maniera sintetica: accruals);
i sostenitori del metodo reddituale ritengono che sia più utile ed opportuno (nell’ottica della definizione del valore del capitale) utilizzare flussi di risultato che tengono conto degli accruals, in modo da poter cogliere tutta la valenza segnaletica di un risultato determinato “per competenza”, piuttosto che (alla luce della discrezionalità che necessariamente si accompagna alla determinazione/quantificazione degli stessi accruals e del pervenire attraverso ad essi ad una configurazione di risultato “non immediatamente consumabile”) determinare un risultato che prescinda in toto dalla loro considerazione (quale il flusso monetario). I sostenitori della Tesi contrapposta tenderanno invece ad utilizzare il modello finanziario, ritenendo che, anche in sede di valutazione, “Cash is King”.
Le caratteristiche del capitale economico. La dottrina
Definito il capitale economico come quella grandezza che tiene conto di ogni elemento in grado di contribuire alla futura produzione di ricchezza, si è visto, con l’ausilio della “Teoria del valore”, che questa capacità di creare ricchezza è generalmente riflessa nell’attitudine del complesso aziendale di generare risultati futuri quantomeno “soddisfacenti” (oltre che, ovviamente, di mantenere l’integrità del capitale investito).Il valore attribuibile ad un’azienda è, di conseguenza, funzione dei “frutti” che essa è in grado di generare nel tempo; in altri termini il valore assegnabile ad un complesso aziendale varia in ragione della quantità e della qualità dei risultati che esso sarà in grado di generare. I valori-flusso (in quanto tali) si distribuiscono nel tempo, e dunque nel futuro; in larga parte devono pertanto essere oggetto di stima: si tratta, a tutti gli effetti, di effettuare delle previsioni e di determinare dei flussi attesi.
Questo processo di stima porta chiaramente a determinare valori di capitale diversi a seconda dei criteri, dei requisiti e delle limitazioni dei quali si impone il rispetto; sulla base di questo la dottrina ha da lungo tempo distinto le stime che conducono a valori di capitale economico da quelle che portano a valori di capitale potenziale. Tra le prime sono classificate le stime che rispettano i seguenti requisiti: generalità (o astrattezza), razionalità e dimostrabilità.Una valutazione è generale quando prescinde dagli interessi delle parti coinvolte nella negoziazione, dalla forza contrattuale che esse esprimono in fase di negoziazione, nonché da effetti contingenti di domanda ed offerta; il rispetto di questi criteri porta di conseguenza alla definizione di un valore generale, vale a dire “il prezzo che in circostanze normali, astrazion fatta dalle parti in causa, dei loro particolari interessi e dello stato di cose esistente, può essere considerato come adeguato”.Una valutazione generale-astratta mira quindi a stimare il valore intrinseco dell’azienda; da ciò discende che essa deve essere condotta avendo a riferimento l’azienda nel suo essere stand-alone, vale a dire prescindendo dalla considerazione degli effetti (potenziali) determinati sui suoi valori di capitale da eventuali operazioni (fusioni, acquisizioni ecc).In caso contrario è evidente che non si tratterebbe infatti di stimare il valore aziendale “intrinseco”; si tratterebbe altresì di un valore che tiene in considerazione potenzialità (quali le “celebri” sinergie) che non attengono al complesso aziendale astrattamente considerato, ma che al contrario vengono dispiegate solo in relazione alla modifica di alcune delle condizioni di gestione che lo caratterizzavano prima dell’operazione.
Il criterio della razionalità fa invece riferimento alla validità concettuale e alla consistenza teorica alle quali il processo valutativo si deve globalmente informare.Una valutazione è infine dimostrabile quando da un lato le quantità utilizzate nella formula prescelta hanno un accettabile grado di obiettività (e quindi di credibilità) e dall’altro tutto il processo valutativo poggia su ipotesi realistiche e conformi alla realtà esaminata.Le valutazioni che non presentano i tre questi requisiti appena elencati esprimono invece valori di “capitale potenziale”. Data la centralità che la dottrina (ed in misura significativa anche la prassi) assegna alla distinzione tra questi due concetti sembra opportuno approfondire l’argomento e descrivere in che modo esso rilevi nella pratica.Innanzitutto, le diverse tipologie di formule che si possono adottare per valutare un’azienda possono essere in primis distinte tra quelle basate sui “flussi di risultato” e quelle che da essi prescindono, quali i metodi patrimoniali, i multipli e le “regole del pollice”.Le prime possono poi considerare diverse tipologie di flussi (reddituali, monetari, ma anche di “valore aggiunto”), con un diverso grado di analiticità (flussi puntualmente determinati, calcolo di un flusso medio atteso o medio-normale, utilizzo per i primi n anni di flussi analitici e in seguito di un flusso medio atteso, ecc); possono essere inoltre distinte per l’orizzonte temporale cui si spingono le previsioni dei flussi (breve termine o lungo periodo), e per la considerazione o meno di eventuali sinergie ed opportunità di crescita.
Tra le molteplici configurazioni di metodi e formule che si possono ottenere combinando le suddette caratteristiche, non tutte sono idonee ad esprimere valutazioni generali/astratte, razionali e dimostrabili e pertanto stimare valori di capitale economico.Ad esempio Luigi Guatri afferma che “simili caratteristiche sono (solo) riconoscibili ai metodi reddituali basati sui flussi attesi di cui sia ragionevolmente dimostrabile la raggiungibilità, cioè legate a capacità reddituali già acquisite o di probabile (se non proprio certo) raggiungimento nel breve termine”.Altra parte della dottrina ritiene che anche il metodo finanziario sia idoneo ad esprimere valori di capitale economico, a condizione che i “flussi grezzi” previsti nel piano vengano opportunamente normalizzati e vengano apportate altre rettifiche (che saranno trattate nel caso di seguito affrontato) per determinare, in sostanza, un flusso monetario ragionevolmente stabile e legato a capacità aziendali “in atto” e non solo potenziali. Per inciso, il metodo finanziario viene sovente utilizzato per stimare il valore di aziende “mature” e che operano in ambiti stabili; nei contesti caratterizzati da tali condizioni l’ammontare annuo degli investimenti in immobilizzazioni (“investimenti di sostituzione”) è pari in media alla quantità degli ammortamenti contabili delle immobilizzazioni stesse, per cui la differenza tra flusso reddituale e finanziario risulta in genere considerevolmente ridotta.
Si può a questo punto affermare che la distinzione tra valori di capitale economico e di capitale potenziale verte, in sintesi, sulla qualità dei flussi che vengono utilizzati nelle diverse formule; se questi sono legati a capacità “in atto”, vale a dire dimostrabili sulla base dei risultati già conseguiti o ragionevolmente conseguibili, si determineranno valori di capitale economico; se al contrario gli stessi flussi sono il frutto di stime fondate su attese a lungo termine che considerano potenzialità ancora da esprimere ed in quanto tali difficilmente dimostrabili (quali “possibili sinergie” od incrementi di risultati conseguibili per la futura entrata in nuovi mercati) si perverrà a stime di capitale potenziale.
Capitale economico e capitale potenziale nella prassi; il campo delle garanzie societarie
La pratica delle valutazioni aziendali nasce storicamente nell’ambito delle operazioni di gestione (o finanza) “straordinaria”; si tratta di situazioni che richiedono di fatto l’accertamento, in un dato momento, del valore aziendale. Nello specifico, questo valore viene ad essere stimato prevalentemente per finalità “di garanzia societaria” (spesso, ma non esclusivamente, dei soci di minoranza).A titolo di esempio, tra queste operazioni si comprendono:
- trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni dell’azienda, di un suo ramo o di quote sociali, recesso oppure ingresso di un socio, aumenti di capitale, offerte pubbliche di acquisto (O.P.A.) e offerte pubbliche di vendita (O.P.V.), emissione di prestiti obbligazionari con warrant oppure convertibili, scelta del prezzo iniziale di quotazione (I.P.O.) nonché procedure concorsuali in genere.In molte di queste operazioni si tratta per l’appunto di regolare i rapporti trai soci attuali, oppure tra soci attuali e potenziali (e talvolta anche tra questi ed altri stakeholders) sulla base del valore attribuibile al capitale aziendale; valore che deve essere di conseguenza il più “oggettivo” ed obiettivo” possibile, onde evitare (o meglio ridurre) le possibili contestazioni che inevitabilmente sorgono in questa fase.A tutta evidenza, si tratta di situazioni in cui l’attribuire, per esempio, un maggiore valore al capitale aziendale rispetto a quello “reale/intrinseco” comporta:
- un guadagno per i soggetti che traggono vantaggio dall’attribuzione di un valore al capitale aziendale maggiore rispetto al suo “valore intrinseco” (o “reale”); è il caso che riguarda per esempio la compagine azionaria che decide di uscire (in parte o in toto) dal capitale aziendale tramite la messa in vendita sul mercato di Borsa delle azioni, attraverso un’operazione di O.P.V., in cui è prevista per legge la definizione di un prezzo iniziale di vendita delle azioni stesse;
- in maniera speculare, ciò comporta una perdita per i soggetti che dall’eventualità di cui sopra traggono diretto svantaggio, vale a dire, nell’esempio riportato, i soggetti potenziali acquirenti delle azioni “sopravvalutate”: essi conseguiranno più precisamente una perdita pari in valore assoluto al guadagno dei soggetti cedenti le azioni. Quest’ultima considerazione rende chiaro come in tutte le operazioni “a somma zero” (in cui cioè il guadagno di un soggetto è compensato dalla perdita di un altro soggetto) la definizione del valore del capitale sulla base del quale avvengono le successive transazioni deve essere quanto più oggettiva e dimostrabile, onde evitare contestazioni che possono anche sfociare in iniziative giudiziarie.Date queste premesse, sembra comprensibile come non sia opportuno assegnare il compito di valutare il capitale aziendale né al “soggetto compratore” e né al “soggetto venditore” (e più in generale ai soggetti più direttamente coinvolti nell’operazione); nella realtà si ricorre in effetti a delle stime effettuate da soggetti terzi (seguendo quindi uno schema di tipo “arbitrale”), nello specifico a dei periti o operatori di merchant banks che si presumono essere indipendenti.D’altra parte anche questi “soggetti terzi” devono pervenire ad una valutazione del valore del capitale minimizzando la possibilità che questa sia poi contestata (o sia messa in dubbio la buona fede dell’autore della stima); per ottenere questo obiettivo, risulta comprensibile come la valutazione debba essere quanto più dimostrabile, razionale e generale-astratta: in altri termini, deve essere anch’essa una valutazione di “capitale economico”.Sembra superfluo sottolineare che valutazioni di capitale potenziale, ovvero che considerano capacità di generare risultati non facilmente dimostrabili (in quanto sostanzialmente slegate dalle capacità “in atto” al momento della valutazione, in cui il nesso tra risultati attuali e risultati futuri previsti risulta molto labile) sarebbero senz’altro contestate (anche agevolmente) dai soggetti che ne risultano potenzialmente danneggiati.
Nulla vieta peraltro che valutazioni di capitale potenziale siano esperite nell’ambito delle “stime di parte”, come in effetti avviene nella pratica; in questo caso diverse sono gli scopi ed i presupposti della valutazione, ed in particolare si prescinde dalle finalità “di garanzia” cui di norma fanno riferimento le valutazioni effettuate nell’ambito delle c.d. “operazioni straordinarie”.
Il capitale economico, gli IAS e il “fair value”
Autorevole dottrina afferma che “l’adozione degli IAS è paragonabile, per importanza, all’introduzione del conto economico analitico avvenuto in Italia nel 1974, comportando una vera e propria rivoluzione alle fondamenta della contabilità, riconducibile in primo luogo, al passaggio dallo storico principio del costo al principio del fair value”; quest’ultimo è definito dallo IASC come “the price at which an asset or liability could be exchanged in a current transaction between knowledgeable, unrelated willing parties”.
Dall’espressione sopra riportata si comprende come l’obiettivo della misurazione del fair value sia quello di stimare un prezzo di scambio di un’attività o di una passività, in assenza però di una transazione “corrente” tra due parti avente come oggetto l’attività o la passività in questione (la quale farebbe emergere un prezzo reale e concreto, vale a dire un dato); si fa riferimento quindi a una transazione ipotetica tra parti consapevoli, operanti in assenza di obblighi e costrizioni, che si trovano in situazione di parità per quanto riguarda competenze, abilità e possesso di informazioni rilevanti sul valore del bene oggetto di scambio. Il punto centrale della questione sembra pertanto essere l’individuazione (attraverso una chiara gerarchia di metodi e tecniche di valutazione, qui non riportati) di un prezzo che dovrebbe replicare quello osservato in una libera transazione tra le parti, e sulla base di quest’ultimo prezzo valutare le attività e le passività aziendali.
A questo punto è opportuno fare un passo indietro. Nei paragrafi precedenti si è detto che la nozione di capitale economico si differenzia dai concetti di capitale di funzionamento (o di bilancio) e capitale di liquidazione in quanto attraverso di essa si mira ad individuare il valore effettivamente attribuibile ad un complesso aziendale (funzionante), valore sulla base del quale le parti coinvolte in una transazione determineranno poi un prezzo effettivo. A questo riguardo, l’introduzione attraverso i principi IAS del concetto di fair value nella “roccaforte” della contabilità di bilancio (che si traduce in primis nella sostituzione dello storico principio del costo) dovrebbe consentire di pervenire ad una “rappresentazione del capitale più vicina al valore economico dell’azienda”.A tutta evidenza, il valutare gli asset e le passività aziendali al loro (presunto) valore equo di mercato (maggiore o minore che sia rispetto al rispettivo costo storico) dovrebbe consentire un apprezzamento del capitale aziendale che è più vicino al suo “valore di capitale economico” di quanto non lo sia il patrimonio netto contabile determinato con i criteri convenzionali.In tal modo si presume che le informazioni che i lettori del documento di bilancio riescono a trarre dallo stesso possano essere più significative, in quanto “più vicine” alla realtà dei fatti.In altri termini, perseguire l’obiettivo della rilevanza dell’informazione diffusa tramite il documento di bilancio, anche a scapito del principio della prudenza, costituisce, nelle intenzioni, un tentativo di far rappresentare alla contabilità aziendale la sostanza degli accadimenti economici che impattano sulla realtà aziendale.In quest’ottica va letto, ad esempio, la sostituzione dell’ammortamento sistematico della grandezza “avviamento” con il processo di impairment test, volto a verificare annualmente in che misura sussistono i presupposti che hanno comportato un determinato valore di iscrizione della grandezza stessa in bilancio e in che misura una modifica di questi presupposti (positiva o negativa che sia) incida sull’entità da indicare in bilancio.